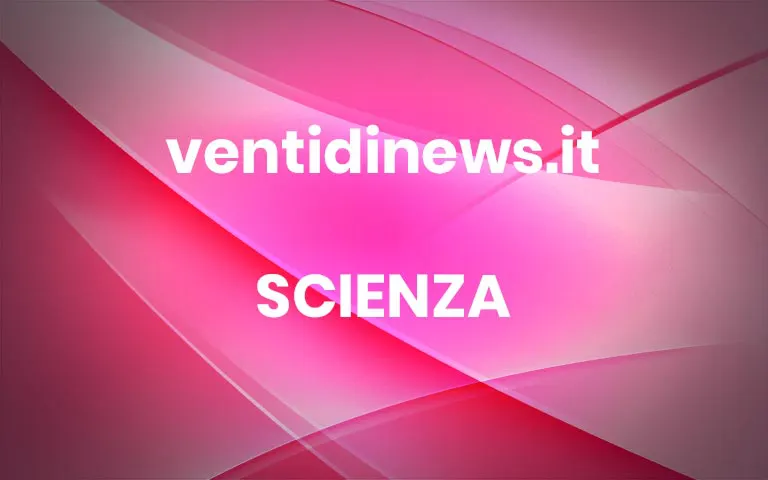Anche nei mari si raggiungono nuovi record di temperatura
Ultimamente si stanno registrando nuovi record di temperatura non solo nell’aria vicina al suolo, ma anche negli oceani e nei mari. Il 24 luglio una boa nella Baia dei Lamantini, circa 65 chilometri a sud di Miami, in Florida, ha registrato 38,4 °C, che potrebbe essere la più alta temperatura marina mai rilevata, se la misura sarà confermata. Il record precedente risaliva all’estate del 2020, quando nel Golfo Persico, vicino al Kuwait, erano stati registrati 37,6 °C. E sempre il 24 luglio la temperatura superficiale media del mar Mediterraneo ha raggiunto 28,4 °C: anche in questo caso si tratta di un record, finora la media più alta erano i 28,25 °C dell’agosto del 2003.L’innalzamento delle temperature marine è una parte del riscaldamento globale causato dalle attività umane che si percepisce poco nella vita quotidiana, ma preoccupa da tempo la comunità scientifica che si occupa di clima e quest’anno ha attirato l’attenzione in modo particolare. Tra la fine di marzo e l’inizio di aprile infatti la media globale della temperatura marina superficiale aveva raggiunto il valore più alto mai registrato (21,05 °C) secondo i dati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale statunitense che si occupa di meteorologia. In particolare si erano registrati valori di temperatura molto alti rispetto alla media nel nord dell’oceano Atlantico. Poi a maggio e a giugno i valori delle temperature medie delle superfici marine sono stati i più alti mai registrati per quei mesi, superando anche di 0,5 °C i record precedenti.Secondo il Climate Change Service di Copernicus, il programma di collaborazione scientifica dell’Unione Europea che si occupa di osservazione della Terra, a causa delle temperature particolarmente alte raggiunte nel nord dell’Atlantico ci troviamo in un «territorio sconosciuto» per quanto riguarda il contesto meteorologico.Secondo le prime valutazioni dei climatologi questi record sono stati dovuti al più generale riscaldamento globale in combinazione con altri fattori che ancora non sono stati definiti con precisione. A giugno Albert Klein Tank, direttore dello Hadley Centre del Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito, aveva ipotizzato che c’entrasse l’indebolimento di alcuni venti che normalmente portano sabbia del deserto del Sahara al di sopra dell’Atlantico settentrionale e ne abbassano le temperature, perché la sabbia riflette la luce solare.Negli ultimi sette anni, ogni anno, le temperature medie degli oceani sono aumentate rispetto al precedente e nel 2022 hanno raggiunto i valori massimi dagli anni Cinquanta, quando si cominciarono a registrare con sistematicità. Il riscaldamento dei mari è un problema per varie ragioni: causa morie di animali e piante marine, contribuisce all’innalzamento del livello del mare (perché maggiore è la temperatura dell’acqua minore è la sua densità, e quindi maggiore il volume che occupa) e favorisce i fenomeni meteorologici estremi come gli uragani negli oceani e i grossi temporali nel bacino del Mediterraneo. Infatti tanto più sono caldi gli strati superficiali dell’acqua, maggiore è l’evaporazione dell’acqua e dunque l’umidità nell’aria che può intensificare le precipitazioni.#ImageOfTheDayThe marine heatwave sweeping across the Mediterranean Sea is hitting record highs, particularly in the central basinAccording to @CMEMS_EU, sea temperature anomalies have spiked to +5.5°C along the coasts of Italy, Greece and North Africa ♨️ pic.twitter.com/NcHpboKP60— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) July 27, 2023Finora le temperature marine sono aumentate meno rispetto a quelle atmosferiche: in media di circa 0,9 °C rispetto ai livelli pre-industriali, mentre quella media dell’aria vicina al suolo è aumentata di 1,5 °C rispetto allo stesso periodo, cioè rispetto a prima che i paesi più ricchi cominciassero a diffondere grandi quantità di gas serra nell’atmosfera. Si stima che circa il 90 per cento del calore ceduto all’atmosfera dalle attività umane sia stato assorbito dagli oceani, che però hanno potuto assorbirne molto senza grosse ripercussioni per decenni.L’anomalia di temperatura, cioè la differenza rispetto alla temperatura media della superficie marina nel periodo 1971-2000, per la giornata del 24 luglio 2023 secondo i dati preliminari della NOAA; nell’Atlantico settentrionale e nel Mediterraneo si sono registrate temperature medie di 5 o anche 6 °C superiori alla media storica– Leggi anche: In Italia le grandinate sono aumentate LEGGI TUTTO