IN EVIDENZA

Omicidio Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla, ha simulato l’incidente»
Secondo il giudice per le indagini preliminari, Giampiero Gualandi avrebbe volontariamente ucciso l’ex vigilessa Sofia Stefani, con cui pare avesse una relazione extraconiugale, che andava avanti da diversi mesi. Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla» – Nanopress.itDalle prime indagini sarebbe emerso che la vittima non volesse troncare il rapporto, cosa che invece desiderava fare Gualandi, come confermato i messaggi inviati dall’ex comandante dei vigili alla donna. Il giorno del delitto risultano quindici telefonate partite dal cellulare della vittima verso quello di Gualandi. Secondo il gip, che ha confermato la detenzione per l’ex capo dei vigili urbani, esiste una spiccata pericolosità sociale e il rischio di reiterazione del reato da parte dell’indagato. Omicidio Sofia Stefani, secondo il gip Gualandi voleva ucciderlaNessun incidente. Secondo la ricostruzione fatta dal giudice Domenico Truppa, quando Sofia Stefani e Giampiero Gualandi si sono chiusi in stanza al comando della polizia locale di Anzola, lo scorso 16 maggio, l’uomo aveva già in mente l’omicidio. La discussione tra i due, tra cui pare ci fosse una relazione sentimentale che andava avanti da alcuni mesi, sarebbe stata scatenata dalla volontà della vittima di continuare la storia, mentre Gualandi era esasperato e logorato dalla presenza della donna nella sua vita, tanto da voler chiudere tutti i ponti con lei. A confermarlo i messaggi scoperti sul cellulare dell’uomo.Secondo il gip, che ha confermato la detenzione per l’ex capo dei vigili urbani, esiste una spiccata pericolosità sociale e il rischio di reiterazione del reato da parte dell’indagato. La ricostruzione del delittoStando a quanto ricostruito finora, Gualandi avrebbe pianificato l’azione omicida. Quella mattina ha ritirato la pistola dall’armeria e recuperato la scatola per la pulizia, predisponendo una linea di difesa. Quando Sofia Stefani è arrivata in ufficio, Gualandi l’ha uccisa e ha raccontato che il colpo era partito per sbaglio. A quel punto ha allertato il 118, per chiedereI messaggi tra i due nei giorni precedenti al delitto avrebbero confermato le intenzioni di Gualandi. La mattina in cui l’ex vigilessa è stata uccisa, dal cellulare della vittima sono state effettuate quindici chiamate a quello dell’indagato. Gualandi avrebbe premuto il grilletto per “chiudere definitivamente i conti con una persona che lo ossessionava da alcuni mesi in maniera incessante”. Intanto, mentre prende il via l’esame autoptico sul corpo della vittima, il legale di Giampiero Gualandi ha già annunciato che, la prossima settimana, verrà depositato il ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del suo assistito o la misura degli arresti domiciliari. LEGGI TUTTO
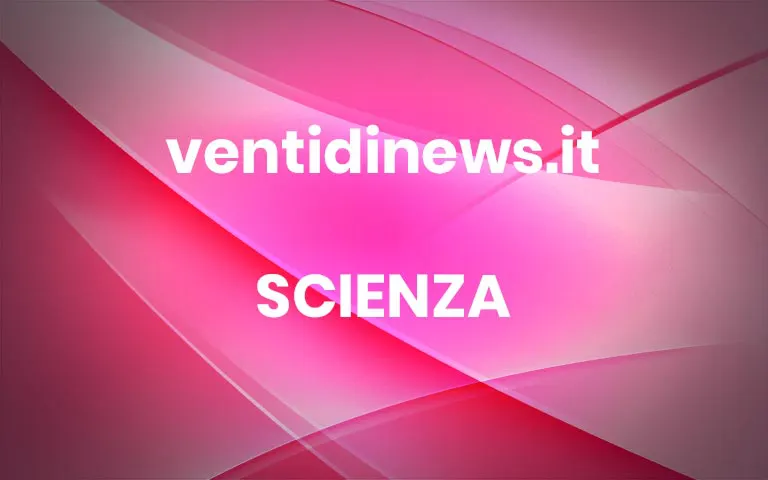

Si fa presto a dire test di Turing
Caricamento playerL’8 giugno di settant’anni fa Alan Turing fu trovato morto nella propria casa di Wilmslow, in Inghilterra, dalla sua governante. Le analisi sul suo corpo portarono alla conclusione che uno dei più brillanti pionieri dell’informatica fosse morto il giorno prima – il 7 giugno – a causa di un avvelenamento da cianuro. Vicino al suo corpo c’era una mela mangiata a metà: si ipotizzò che Turing l’avesse usata per mascherare il sapore del veleno, ma non fu mai analizzata per verificare se contenesse tracce di cianuro. Turing morì dopo un periodo di grandi difficoltà, definito dalle leggi dell’epoca un criminale per la propria omosessualità e sottoposto alla castrazione chimica, dopo aver dato un contributo fondamentale all’informatica e allo sviluppo del concetto di “intelligenza artificiale”.
Solo nel 2009, a più di mezzo secolo dalla sua morte, il governo britannico espresse il proprio rammarico per il trattamento riservato a Turing, così come alle migliaia di altre persone condannate per la loro omosessualità. Furono poi necessari altri quattro anni prima che la regina Elisabetta II concedesse a Turing una grazia postuma, riconoscendo il suo importante contributo per il progresso e la pace, soprattutto in un periodo drammatico come quello della Seconda guerra mondiale.
Turing fu infatti uno dei protagonisti delle decodifica dei messaggi realizzati con Enigma, la macchina sviluppata dai nazisti per comunicare in codice e organizzare gli attacchi soprattutto contro i sottomarini degli Alleati, come raccontato nel film The Imitation Game con Benedict Cumberbatch. Ma il contributo più grande di Turing fu nello studio e nelle riflessioni intorno al rapporto tra gli esseri umani e le macchine, in un periodo in cui l’informatica per come la intendiamo oggi era agli albori e gli scenari in cui i computer avrebbero risolto molti dei nostri problemi sembravano ancora da fantascienza.
Prima della Seconda guerra mondiale e di Enigma, Turing immaginò nei suoi studi una macchina in grado di svolgere qualsiasi compito, prospettando caratteristiche e funzionamenti non molto lontani da quelli dei computer che usiamo ogni giorno, smartphone compresi. Turing riteneva che la sua ipotetica macchina sarebbe stata in grado di rispondere a specifiche esigenze, a patto di fornirle un programma adeguato per farlo.
Ma Turing era soprattutto affascinato dalla possibilità che un giorno le macchine potessero diventare sofisticate al punto da sembrare umane. Illustrò l’idea in un articolo pubblicato nel 1950 sulla rivista accademica Mind, descrivendo un esperimento per mettere alla prova un sistema artificiale in una conversazione tra esseri umani.
Fin dall’inizio dell’articolo Turing chiariva la difficoltà del problema: «Propongo di prendere in considerazione la seguente questione: “Le macchine possono pensare?”». La riflessione proseguiva segnalando come fosse difficile definire il concetto stesso di “pensare”, arrivando alla proposta di un gioco-test basato per lo più sul linguaggio da considerare come un’espressione di intelligenza.
Una versione di Enigma (Getty Images)
Nel corso del tempo sarebbero state elaborate varie versioni del test, oggi noto come “Test di Turing” dal nome del suo inventore, ma ci sono spesso elementi comuni. Nel test un valutatore deve essere in grado di distinguere veri interlocutori da un interlocutore artificiale, naturalmente senza poterli vedere e sapendo che uno di loro è una macchina. Il sistema artificiale supera la prova se il valutatore non riesce a distinguerlo dagli esseri umani.
Nonostante fosse stato presentato in un articolo in parte speculativo e “minore” rispetto ad altre ricerche svolte da Turing – e non fosse definito esplicitamente come un modo per misurare l’intelligenza di un sistema – il test che porta il suo nome sarebbe diventato negli anni un importante punto di riferimento per chi si occupa di informatica e di sistemi di intelligenza artificiale. A oltre 70 anni dalla sua pubblicazione, si discute ancora oggi sulla possibilità che una macchina sviluppi una propria coscienza, tale da consentirle di articolare un pensiero e di averne consapevolezza.
Nel corso del tempo il test di Turing avrebbe ricevuto diverse critiche per una certa ingenuità, dimostrata dal fatto che alcuni dei vincoli previsti possono essere facilmente aggirati per dare l’illusione al valutatore di avere effettivamente a che fare con un essere umano, anche se sta interagendo con una macchina fortemente limitata ma programmata per nascondere i propri limiti. Anche per questo motivo nacquero test alternativi, pur basati sugli assunti di Turing.
ELIZA, un programma sviluppato negli anni Sessanta negli Stati Uniti, dava risposte all’apparenza “intelligenti” imitando uno psicologo. Il sistema suggeriva con una certa frequenza ai propri interlocutori umani di riflettere sulle loro affermazioni, proprio come avrebbe fatto un terapista, semplicemente componendo le proprie frasi in domande che contenevano parte delle risposte appena ricevute. Secondo alcuni parametri, ELIZA superava il test e in un recente studio ha anche battuto una delle versioni di GPT, il sistema di intelligenza artificiale che fa funzionare il famoso ChatGPT.
Che un sistema concepito 60 anni fa, quando i computer avevano una frazione della capacità di calcolo di quelli attuali, ne abbia superato uno recentissimo e molto discusso proprio per le sue capacità si spiega col fatto che non esiste un’unica versione formalizzata del test. L’idea di base è quella che fu esposta da Alan Turing a metà Novecento, ma i modi in cui viene effettuato il test possono variare sensibilmente in base ai criteri scelti dai gruppi di ricerca che se ne occupano.
Essendo il sistema più conosciuto e studiato degli ultimi anni, ChatGPT è finito al centro di molte sperimentazioni anche tese a verificare la sua capacità di produrre conversazioni così verosimili da poter essere scambiate per quelle prodotte da un essere umano.
Nel luglio del 2023 un articolo pubblicato su Nature ha segnalato il superamento del test di Turing da parte di ChatGPT, pur evidenziando come rimangano irrisolti molti problemi legati al produrre sistemi che siano effettivamente in grado di ragionare. Alcuni particolari sistemi di AI come ChatGPT sono basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per la generazione di testi, che prevedono le parole da utilizzare man mano che scrivono una frase senza che abbiano una consapevolezza di ciò che stanno facendo (per alcuni esperti è un problema secondario, nel momento in cui una AI svolge comunque efficacemente il compito che le è stato assegnato).
A inizio 2024 un altro studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, ha segnalato come la versione all’epoca più recente di ChatGPT producesse conversazioni non distinguibili da quelle dei suoi interlocutori umani, rivelando le proprie origini artificiali solo nel caso di risposte orientate in modo più marcato alla cooperazione e all’altruismo. La sperimentazione era stata effettuata basandosi su una serie di test solitamente somministrati per verificare la personalità e le scelte in particolari scenari, di tipo etico ed economico. Secondo il gruppo di ricerca, lo studio dimostra uno dei primi casi in cui una intelligenza artificiale ha superato «un rigoroso test di Turing», ma per alcune delle risposte fornite «non avrebbe probabilmente guadagnato molti amici».
L’esperimento non può comunque essere considerato definitivo, visto che la questione del test di Turing e più in generale della capacità delle macchine di pensare è ancora ampiamente discussa tra chi si occupa di filosofia, di informatica e di matematica. La proposta di Turing non era del resto orientata a dare risposte, ma a fare domande: non aveva pensato il proprio test come una prova di intelligenza e umanità, ma come un gioco, una gara di imitazione. Lo immaginò in un’epoca molto diversa dalla nostra, dove sarebbe stato già sorprendente di per sé avere un programma che risponde a delle domande ed è in grado di portare avanti una conversazione.
Oggi sappiamo che quei sistemi esistono, sono ormai nella nostra vita di tutti i giorni, ma sappiamo anche che non hanno consapevolezza di sé e che non “pensano”. E quando arriviamo a quest’ultima conclusione, ci interroghiamo su che cosa significhi davvero “pensare”, un concetto per nulla banale e sul quale si ragiona e specula praticamente da sempre. Turing era consapevole dell’impossibilità di dare una risposta convincente alla definizione di quel concetto, ancor prima di applicarlo alle macchine.
Una statua dedicata ad Alan Turing a Manchester, Regno Unito (Getty Images)
Di certo Turing avrebbe osservato con interesse i progressi raggiunti nel campo delle AI negli ultimi anni, visto che già nel suo articolo del 1950 ammetteva che «Le macchine mi sorprendono con grande frequenza», aggiungendo poi:
L’idea che le macchine non possano suscitare sorprese è dovuta, a mio avviso, a un errore a cui sono particolarmente soggetti filosofi e matematici. Deriva dal presupposto che non appena un fatto viene presentato a una mente, tutte le conseguenze di quel fatto affiorano nella mente simultaneamente con esso. È un presupposto molto utile in molte circostanze, ma si dimentica troppo facilmente che è falso. Una conseguenza naturale di ciò è che si presuppone che non vi sia alcuna virtù nel mero elaborare conseguenze partendo da dati e principi generali.
Alan Turing morì a 41 anni in circostanze mai completamente chiarite e che ancora oggi lasciano aperte molte domande. Due anni prima della sua morte, la polizia stava indagando su un furto avvenuto nella sua casa e Turing ammise di avere avuto una relazione fisica con un uomo, che gli aveva riferito di conoscere l’identità di chi aveva commesso il furto e che sarebbe stato quindi utile alle indagini. Nel marzo del 1952 Turing fu accusato di «grave indecenza e perversione sessuale» e si dichiarò colpevole e fu condannato alla castrazione chimica attraverso l’assunzione di estrogeni. La condanna per omosessualità comportò la fine dell’accesso da parte di Turing ai documenti e alle attività governative secretate, per esempio legate alle attività di intelligence durante la Guerra Fredda, nonostante pochi anni prima avesse dato un contributo importante nel decifrare i messaggi di Enigma.
Il corpo di Alan Turing fu cremato due giorni dopo la morte e le ceneri furono disperse nel giardino del crematorio, nel punto in cui anni prima erano state disperse le ceneri di suo padre.
***
Dove chiedere aiutoSe sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22. LEGGI TUTTO


Ue: accordo Italia-Albania sui migranti deve rispettare il diritto europeo
Ascolta la versione audio dell’articolo3′ di lettura«Quando estendono l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che attuano il diritto dell’Unione a situazioni che esulano dall’ambito di applicazione di quest’ultimo, gli Stati membri devono farlo in modo da non compromettere o eludere l’applicazione delle norme armonizzate o degli obblighi da esso previsti». Lo afferma il commissario europeo alla Migrazione Magnus Brunner in risposta a un’interrogazione presentata da diversi esponenti del M5s, Pd e Avs sul protocollo Italia-Albania e la conformità al diritto europeo del trasferimento di migranti in Paesi terzi, precedentemente esclusa dalla Commissione europea.Lo spazio di manovra degli accordi bilaterali «Per quanto riguarda l’iniziativa condotta dall’Italia a seguito della firma di un protocollo sulla gestione della migrazione con l’Albania, l’attuazione di tale protocollo ai sensi del diritto italiano non deve compromettere il sistema europeo comune di asilo o incidere negativamente sulle norme comuni dell’Ue – sottolinea il commissario -. Deve inoltre essere complementare alle vie di accesso all’asilo esistenti e non può frapporsi alle finalità e agli obiettivi del diritto dell’Unione in quest’ambito, né ledere i diritti e le garanzie che gli Stati membri devono concedere alle persone che si trovano in queste situazioni».Loading…Accordo Italia Albania, via libera definitivo del Senato con 93 sì e 61 no«Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, l’iniziativa dell’Italia mira a trasferire determinate categorie di cittadini di paesi terzi intercettati in alto mare verso centri situati in territorio albanese, ma soggetti alla giurisdizione italiana, affinché ne vengano esaminate le domande di protezione internazionale. In caso di rifiuto di tali domande, l’Italia effettuerebbe procedure di rimpatrio da tali centri», prosegue Brunner.Monitoraggio confermato«Ai sensi della direttiva rimpatri, il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare può essere rimpatriato nel proprio paese di origine, in un paese di transito in conformità di accordi di riammissione a livello dell’Ue o bilaterali o di altre intese, o in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato. La Commissione continuerà a seguire da vicino l’attuazione del protocollo Italia-Albania, monitorando in particolare la corretta applicazione del diritto dell’Unione in tale contesto», conclude.Ciriani: su modello Albania governo al lavoro per superare ostacoli“Il progetto in Albania è un’operazione che presenta profili inediti e di complessità rispetto ai quali il Governo è al lavoro per mettere a punto soluzioni in grado di superare gli ostacoli sinora incontrati al fine di consentire la piena funzionalità dei centri realizzati”. Lo ha detto al question time il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, facendo riferimento in particolare al protocollo Italia-Albania messo sotto osservazione dalla Commissione Ue. “Tra l’altro procedure accelerate di frontiera, a partire dal 2026, costituiranno un obbligo per gli Stati membri in virtù del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e le nuove regole europee impongono all’Italia di organizzarsi per l’accoglienza e il trattenimento di diverse migliaia di persone; pertanto gli 880 posti delle strutture in Albania rappresentano un’indiscutibile opportunità”, ha evidenziato Ciriani. “La prosecuzione del progetto si inserisce nella linea tracciata dal Governo sin dal suo insediamento, che mira a ricondurre i flussi migratori entro una cornice di legalità e sostenibilità. In piena coerenza con tale impostazione, il progetto andrà avanti nella convinzione che il contrasto all’immigrazione irregolare, che si avvantaggia dell’utilizzo strumentale delle richieste di asilo, sia la strada da perseguire per combattere gli affari di trafficanti senza scrupoli”, ha aggiunto. LEGGI TUTTO



Saman Abbas, la madre è arrivata in Italia
Condannata all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della figlia, Nazia nega le accuse e sostiene che altri parenti siano i veri responsabili.Saman Abbas, la madre è arrivata in Italia – Nanopress.itOltre a Nazia Shaheen e suo marito Shabbar Abbas, gli altri parenti coinvolti nel caso di Saman Abbas sono: Danish Hasnain, lo zio di Saman, che è stato condannato a 14 anni in primo grado e due cugini di Saman, inizialmente imputati, ma assolti in primo grado. Saman Abbas, la madre è arrivata in ItaliaNazia Shaheen, la madre di Saman, è stata estradata dall’Italia dopo essere stata arrestata in Pakistan. Condannata all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della figlia, Nazia nega le accuse e sostiene che altri parenti siano i veri responsabili. Ora che è in Italia, avrà l’opportunità di fornire la sua versione dei fatti agli inquirenti italiani.L’ultima immagine di Saman con la madre risale alla notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, poco prima che la giovane venisse uccisa per aver rifiutato di lasciare il suo fidanzato, con cui avrebbe voluto presto convolare a nozze. Il caso è ancora in corso e l’appello è previsto per l’autunno. Le dichiarazioni di Nazia potrebbero portare nuovi elementi alla luce.Oltre a Nazia Shaheen e suo marito Shabbar Abbas, gli altri parenti coinvolti nel caso di Saman Abbas sono: Danish Hasnain, lo zio di Saman, che è stato condannato a 14 anni in primo grado e due cugini di Saman, inizialmente imputati, ma assolti in primo grado. LEGGI TUTTO



Viaggio di Meloni in Arabia saudita: in vista nuove cooperazioni. La premier oggi sul Vespucci
Ascolta la versione audio dell’articolo2′ di letturaRafforzare la cooperazione, dalla Difesa ad altri settori strategici. Si inquadra in questa strategia la missione di Giorgia Meloni in Arabia Saudita, dove oggi salirà a bordo dell’Amerigo Vespucci, lo storico veliero della Marina impegnato in un tour mondiale, e poi domenica ad Al’-Ula, città patrimonio dell’Unesco, incontrerà il principe Mohammed bin Salman, prima di spostarsi lunedì in Bahrein per un’altra breve visita ufficiale.Sicurezza energetica e investimentiDa capo del governo Meloni ha scelto di impostare relazioni pragmatiche e ringraziando re Salman e l’erede al trono per gli auguri, appena insediata a Palazzo Chigi manifestò l’interesse alla «cooperazione in materia di sicurezza energetica, investimenti e diritti umani». I primi due capitoli sono fra i dossier centrali della missione in Arabia Saudita, inizialmente programmata in autunno e poi slittata.Loading…Intese da firmareAd Al’-Ula volerà anche una delegazione di imprenditori italiani, nonché manager di società partecipate. E saranno firmate intese. Ci sarà anche Roberto Cingolani, l’amministratore delegato di Leonardo, che un anno fa ha siglato un memorandum di intesa con l’Arabia Saudita per opportunità di collaborazione nell’aerospazio e difesa, e si accinge a definire un accordo in materia di elicotteri. Sullo sfondo c’è anche il concreto interesse dei sauditi a entrare a far parte del Gcap, il programma di Italia, Gran Bretagna e Giappone per la creazione di un nuovo caccia da combattimento: un avvicinamento su cui si starebbero facendo passi avanti.Riad attore strategicoPer Roma, Riad è un attore strategico nello scacchiere mediorientale: è condivisa la necessità di lavorare alla soluzione per due popoli e due Stati, e un dossier di comune preoccupazione è la libera navigazione del Mar Rosso, insidiata dagli Houthi. Il rapporto con i sauditi è strategico per il governo anche sul fronte del Piano Mattei, e i due Paesi sono con India, Usa, Ue, Francia, Germania ed Emirati Arabi Uniti, coinvolti nel progetto di corridoio economico fra India, Medio Oriente ed Europa. Bin Salman, con la sua Vision 2030, punta a una diversificazione dell’economia saudita oltre il petrolio, e l’Italia vuole porsi come partner privilegiato del Regno in questo percorso. Anche in questo senso, ad esempio, vanno il memorandum siglato nel 2023 tra i due governi per la promozione degli investimenti, e quello di una decina di giorni fa per rafforzare la cooperazione su transizione e sicurezza energetica. LEGGI TUTTO



Omicidio Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla, ha simulato l’incidente»
Secondo il giudice per le indagini preliminari, Giampiero Gualandi avrebbe volontariamente ucciso l’ex vigilessa Sofia Stefani, con cui pare avesse una relazione extraconiugale, che andava avanti da diversi mesi. Sofia Stefani, il gip: «Giampiero Gualandi voleva ucciderla» – Nanopress.itDalle prime indagini sarebbe emerso che la vittima non volesse troncare il rapporto, cosa che invece desiderava fare Gualandi, come confermato i messaggi inviati dall’ex comandante dei vigili alla donna. Il giorno del delitto risultano quindici telefonate partite dal cellulare della vittima verso quello di Gualandi. Secondo il gip, che ha confermato la detenzione per l’ex capo dei vigili urbani, esiste una spiccata pericolosità sociale e il rischio di reiterazione del reato da parte dell’indagato. Omicidio Sofia Stefani, secondo il gip Gualandi voleva ucciderlaNessun incidente. Secondo la ricostruzione fatta dal giudice Domenico Truppa, quando Sofia Stefani e Giampiero Gualandi si sono chiusi in stanza al comando della polizia locale di Anzola, lo scorso 16 maggio, l’uomo aveva già in mente l’omicidio. La discussione tra i due, tra cui pare ci fosse una relazione sentimentale che andava avanti da alcuni mesi, sarebbe stata scatenata dalla volontà della vittima di continuare la storia, mentre Gualandi era esasperato e logorato dalla presenza della donna nella sua vita, tanto da voler chiudere tutti i ponti con lei. A confermarlo i messaggi scoperti sul cellulare dell’uomo.Secondo il gip, che ha confermato la detenzione per l’ex capo dei vigili urbani, esiste una spiccata pericolosità sociale e il rischio di reiterazione del reato da parte dell’indagato. La ricostruzione del delittoStando a quanto ricostruito finora, Gualandi avrebbe pianificato l’azione omicida. Quella mattina ha ritirato la pistola dall’armeria e recuperato la scatola per la pulizia, predisponendo una linea di difesa. Quando Sofia Stefani è arrivata in ufficio, Gualandi l’ha uccisa e ha raccontato che il colpo era partito per sbaglio. A quel punto ha allertato il 118, per chiedereI messaggi tra i due nei giorni precedenti al delitto avrebbero confermato le intenzioni di Gualandi. La mattina in cui l’ex vigilessa è stata uccisa, dal cellulare della vittima sono state effettuate quindici chiamate a quello dell’indagato. Gualandi avrebbe premuto il grilletto per “chiudere definitivamente i conti con una persona che lo ossessionava da alcuni mesi in maniera incessante”. Intanto, mentre prende il via l’esame autoptico sul corpo della vittima, il legale di Giampiero Gualandi ha già annunciato che, la prossima settimana, verrà depositato il ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione del suo assistito o la misura degli arresti domiciliari. LEGGI TUTTO
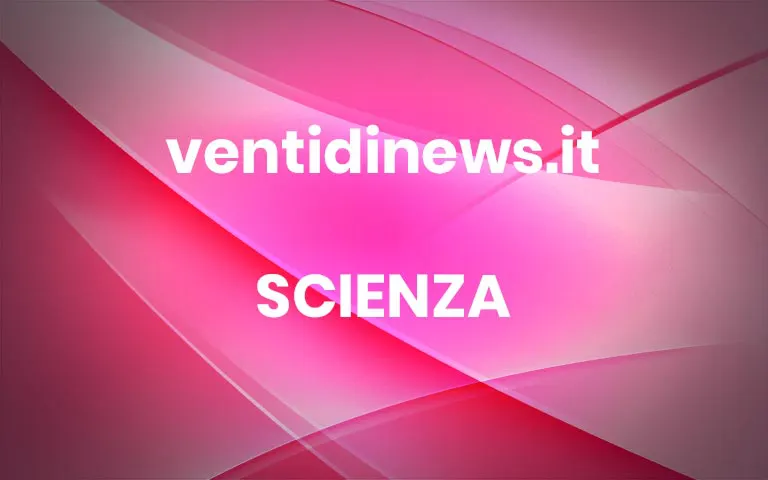

Si fa presto a dire test di Turing
Caricamento playerL’8 giugno di settant’anni fa Alan Turing fu trovato morto nella propria casa di Wilmslow, in Inghilterra, dalla sua governante. Le analisi sul suo corpo portarono alla conclusione che uno dei più brillanti pionieri dell’informatica fosse morto il giorno prima – il 7 giugno – a causa di un avvelenamento da cianuro. Vicino al suo corpo c’era una mela mangiata a metà: si ipotizzò che Turing l’avesse usata per mascherare il sapore del veleno, ma non fu mai analizzata per verificare se contenesse tracce di cianuro. Turing morì dopo un periodo di grandi difficoltà, definito dalle leggi dell’epoca un criminale per la propria omosessualità e sottoposto alla castrazione chimica, dopo aver dato un contributo fondamentale all’informatica e allo sviluppo del concetto di “intelligenza artificiale”.
Solo nel 2009, a più di mezzo secolo dalla sua morte, il governo britannico espresse il proprio rammarico per il trattamento riservato a Turing, così come alle migliaia di altre persone condannate per la loro omosessualità. Furono poi necessari altri quattro anni prima che la regina Elisabetta II concedesse a Turing una grazia postuma, riconoscendo il suo importante contributo per il progresso e la pace, soprattutto in un periodo drammatico come quello della Seconda guerra mondiale.
Turing fu infatti uno dei protagonisti delle decodifica dei messaggi realizzati con Enigma, la macchina sviluppata dai nazisti per comunicare in codice e organizzare gli attacchi soprattutto contro i sottomarini degli Alleati, come raccontato nel film The Imitation Game con Benedict Cumberbatch. Ma il contributo più grande di Turing fu nello studio e nelle riflessioni intorno al rapporto tra gli esseri umani e le macchine, in un periodo in cui l’informatica per come la intendiamo oggi era agli albori e gli scenari in cui i computer avrebbero risolto molti dei nostri problemi sembravano ancora da fantascienza.
Prima della Seconda guerra mondiale e di Enigma, Turing immaginò nei suoi studi una macchina in grado di svolgere qualsiasi compito, prospettando caratteristiche e funzionamenti non molto lontani da quelli dei computer che usiamo ogni giorno, smartphone compresi. Turing riteneva che la sua ipotetica macchina sarebbe stata in grado di rispondere a specifiche esigenze, a patto di fornirle un programma adeguato per farlo.
Ma Turing era soprattutto affascinato dalla possibilità che un giorno le macchine potessero diventare sofisticate al punto da sembrare umane. Illustrò l’idea in un articolo pubblicato nel 1950 sulla rivista accademica Mind, descrivendo un esperimento per mettere alla prova un sistema artificiale in una conversazione tra esseri umani.
Fin dall’inizio dell’articolo Turing chiariva la difficoltà del problema: «Propongo di prendere in considerazione la seguente questione: “Le macchine possono pensare?”». La riflessione proseguiva segnalando come fosse difficile definire il concetto stesso di “pensare”, arrivando alla proposta di un gioco-test basato per lo più sul linguaggio da considerare come un’espressione di intelligenza.
Una versione di Enigma (Getty Images)
Nel corso del tempo sarebbero state elaborate varie versioni del test, oggi noto come “Test di Turing” dal nome del suo inventore, ma ci sono spesso elementi comuni. Nel test un valutatore deve essere in grado di distinguere veri interlocutori da un interlocutore artificiale, naturalmente senza poterli vedere e sapendo che uno di loro è una macchina. Il sistema artificiale supera la prova se il valutatore non riesce a distinguerlo dagli esseri umani.
Nonostante fosse stato presentato in un articolo in parte speculativo e “minore” rispetto ad altre ricerche svolte da Turing – e non fosse definito esplicitamente come un modo per misurare l’intelligenza di un sistema – il test che porta il suo nome sarebbe diventato negli anni un importante punto di riferimento per chi si occupa di informatica e di sistemi di intelligenza artificiale. A oltre 70 anni dalla sua pubblicazione, si discute ancora oggi sulla possibilità che una macchina sviluppi una propria coscienza, tale da consentirle di articolare un pensiero e di averne consapevolezza.
Nel corso del tempo il test di Turing avrebbe ricevuto diverse critiche per una certa ingenuità, dimostrata dal fatto che alcuni dei vincoli previsti possono essere facilmente aggirati per dare l’illusione al valutatore di avere effettivamente a che fare con un essere umano, anche se sta interagendo con una macchina fortemente limitata ma programmata per nascondere i propri limiti. Anche per questo motivo nacquero test alternativi, pur basati sugli assunti di Turing.
ELIZA, un programma sviluppato negli anni Sessanta negli Stati Uniti, dava risposte all’apparenza “intelligenti” imitando uno psicologo. Il sistema suggeriva con una certa frequenza ai propri interlocutori umani di riflettere sulle loro affermazioni, proprio come avrebbe fatto un terapista, semplicemente componendo le proprie frasi in domande che contenevano parte delle risposte appena ricevute. Secondo alcuni parametri, ELIZA superava il test e in un recente studio ha anche battuto una delle versioni di GPT, il sistema di intelligenza artificiale che fa funzionare il famoso ChatGPT.
Che un sistema concepito 60 anni fa, quando i computer avevano una frazione della capacità di calcolo di quelli attuali, ne abbia superato uno recentissimo e molto discusso proprio per le sue capacità si spiega col fatto che non esiste un’unica versione formalizzata del test. L’idea di base è quella che fu esposta da Alan Turing a metà Novecento, ma i modi in cui viene effettuato il test possono variare sensibilmente in base ai criteri scelti dai gruppi di ricerca che se ne occupano.
Essendo il sistema più conosciuto e studiato degli ultimi anni, ChatGPT è finito al centro di molte sperimentazioni anche tese a verificare la sua capacità di produrre conversazioni così verosimili da poter essere scambiate per quelle prodotte da un essere umano.
Nel luglio del 2023 un articolo pubblicato su Nature ha segnalato il superamento del test di Turing da parte di ChatGPT, pur evidenziando come rimangano irrisolti molti problemi legati al produrre sistemi che siano effettivamente in grado di ragionare. Alcuni particolari sistemi di AI come ChatGPT sono basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per la generazione di testi, che prevedono le parole da utilizzare man mano che scrivono una frase senza che abbiano una consapevolezza di ciò che stanno facendo (per alcuni esperti è un problema secondario, nel momento in cui una AI svolge comunque efficacemente il compito che le è stato assegnato).
A inizio 2024 un altro studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, ha segnalato come la versione all’epoca più recente di ChatGPT producesse conversazioni non distinguibili da quelle dei suoi interlocutori umani, rivelando le proprie origini artificiali solo nel caso di risposte orientate in modo più marcato alla cooperazione e all’altruismo. La sperimentazione era stata effettuata basandosi su una serie di test solitamente somministrati per verificare la personalità e le scelte in particolari scenari, di tipo etico ed economico. Secondo il gruppo di ricerca, lo studio dimostra uno dei primi casi in cui una intelligenza artificiale ha superato «un rigoroso test di Turing», ma per alcune delle risposte fornite «non avrebbe probabilmente guadagnato molti amici».
L’esperimento non può comunque essere considerato definitivo, visto che la questione del test di Turing e più in generale della capacità delle macchine di pensare è ancora ampiamente discussa tra chi si occupa di filosofia, di informatica e di matematica. La proposta di Turing non era del resto orientata a dare risposte, ma a fare domande: non aveva pensato il proprio test come una prova di intelligenza e umanità, ma come un gioco, una gara di imitazione. Lo immaginò in un’epoca molto diversa dalla nostra, dove sarebbe stato già sorprendente di per sé avere un programma che risponde a delle domande ed è in grado di portare avanti una conversazione.
Oggi sappiamo che quei sistemi esistono, sono ormai nella nostra vita di tutti i giorni, ma sappiamo anche che non hanno consapevolezza di sé e che non “pensano”. E quando arriviamo a quest’ultima conclusione, ci interroghiamo su che cosa significhi davvero “pensare”, un concetto per nulla banale e sul quale si ragiona e specula praticamente da sempre. Turing era consapevole dell’impossibilità di dare una risposta convincente alla definizione di quel concetto, ancor prima di applicarlo alle macchine.
Una statua dedicata ad Alan Turing a Manchester, Regno Unito (Getty Images)
Di certo Turing avrebbe osservato con interesse i progressi raggiunti nel campo delle AI negli ultimi anni, visto che già nel suo articolo del 1950 ammetteva che «Le macchine mi sorprendono con grande frequenza», aggiungendo poi:
L’idea che le macchine non possano suscitare sorprese è dovuta, a mio avviso, a un errore a cui sono particolarmente soggetti filosofi e matematici. Deriva dal presupposto che non appena un fatto viene presentato a una mente, tutte le conseguenze di quel fatto affiorano nella mente simultaneamente con esso. È un presupposto molto utile in molte circostanze, ma si dimentica troppo facilmente che è falso. Una conseguenza naturale di ciò è che si presuppone che non vi sia alcuna virtù nel mero elaborare conseguenze partendo da dati e principi generali.
Alan Turing morì a 41 anni in circostanze mai completamente chiarite e che ancora oggi lasciano aperte molte domande. Due anni prima della sua morte, la polizia stava indagando su un furto avvenuto nella sua casa e Turing ammise di avere avuto una relazione fisica con un uomo, che gli aveva riferito di conoscere l’identità di chi aveva commesso il furto e che sarebbe stato quindi utile alle indagini. Nel marzo del 1952 Turing fu accusato di «grave indecenza e perversione sessuale» e si dichiarò colpevole e fu condannato alla castrazione chimica attraverso l’assunzione di estrogeni. La condanna per omosessualità comportò la fine dell’accesso da parte di Turing ai documenti e alle attività governative secretate, per esempio legate alle attività di intelligence durante la Guerra Fredda, nonostante pochi anni prima avesse dato un contributo importante nel decifrare i messaggi di Enigma.
Il corpo di Alan Turing fu cremato due giorni dopo la morte e le ceneri furono disperse nel giardino del crematorio, nel punto in cui anni prima erano state disperse le ceneri di suo padre.
***
Dove chiedere aiutoSe sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.Puoi anche chiamare l’associazione Samaritans al numero 06 77208977, tutti i giorni dalle 13 alle 22. LEGGI TUTTO
POLITICA
Dazi Usa, Meloni: “Scelta sbagliata, ma non è una catastrofe”
L’app di Avs contro i dazi di Trump, riconosce l’origine dei prodotti
Meloni: i dazi Usa una scelta sbagliata ma non è una catastrofe. Orsini: no al panico, reagiamo uniti in Europa
Elezioni sindaci, emendamento anti ballottaggio del centrodestra. Opposizioni insorgono












